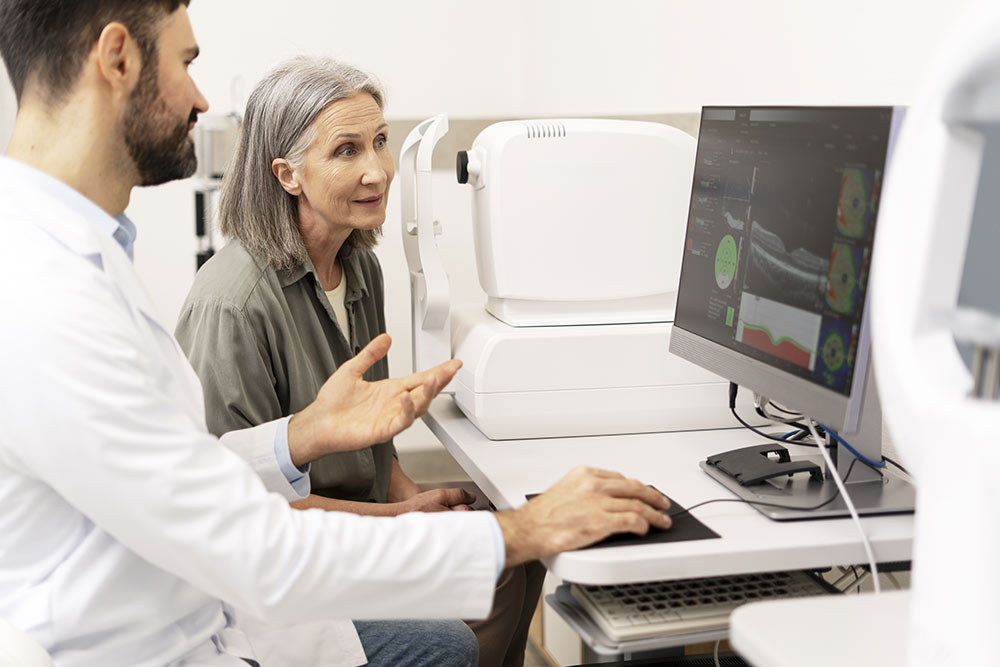Grazie a laser super avanzati e a specialisti sempre più esperti e competenti, oggi la chirurgia refrattiva è una pratica ad altissimo tasso di successo, con una percentuale di rischio per il paziente pari praticamente allo zero. Questo non significa però che non debbano essere prese tutte le accortezze del caso per offrire un intervento sicuro, efficace e dal decorso post-operatorio più rapido possibile. Per questo la visita di idoneità precedente all’operazione è così importante!
Cos’è una visita preoperatoria
La visita preoperatoria – anche chiamata visita di idoneità – è un approfondito controllo oculistico a cui il paziente deve sottoporsi se ha intenzione di correggere il proprio difetto visivo tramite intervento laser. Sebbene la chirurgia refrattiva sia molto sicura – oggi più che mai, grazie alle moderne strumentazioni – non tutti i pazienti presentano i requisiti necessari per prendere parte ai trattamenti, vuoi per patologie oculari o mediche che potrebbero portare a complicazioni, vuoi per caratteristiche che renderebbero l’intervento meno efficace.
Per questo motivo, verificare lo stato di salute generale e degli occhi attraverso specifici esami diagnostici è fondamentale in primo luogo per stabilire se il paziente è idoneo o meno alla chirurgia laser, ma anche per valutare quale sia il percorso più adatto a lui, tra tutte le tecniche disponibili, nonché quali siano i parametri di cui tenere conto per rendere l’intervento ancora più personalizzato.
La visita da effettuare in preparazione all’intervento somiglia in tutto e per tutto a una generica visita oculistica, ma ai classici test di routine si aggiungono degli esami mirati per la valutazione di condizioni particolari.
Preparazione alla visita
La visita preoperatoria è un controllo oculistico approfondito, ma semplice, che non richiede preparazioni particolari, se non qualche piccola accortezza per permettere allo specialista di avere un quadro completo della storia clinica del paziente e all’occhio di quest’ultimo di arrivare riposato agli esami.
Documentazione medica da portare
La visita preoperatoria consiste in parte in esami oculistici mirati e in parte in un consulto con lo specialista, per valutare lo stato di salute del paziente e la sua storia clinica. Per questo motivo viene richiesto di portare con sé in clinica documenti di identità e referti oculistici precedenti.
Nello specifico, il materiale da presentare al medico specialista è il seguente:
- Carta di identità
- Tessera sanitaria
- Cartella clinica contenente le informazioni raccolte durante esami precedenti o eventuali interventi
- Referto oculistico completo, con la gradazione di occhiali e lenti a contatto
- Documenti che attestino assicurazioni o convenzioni (se presenti)
Assieme a questi documenti è anche necessario portare i propri occhiali da vista o da lettura, e – se utilizzate – la confezione delle lenti a contatto, in modo che il medico abbia un quadro completo dei metodi correttivi utilizzati dal paziente.
Storia clinica e anamnesi visiva
La storia clinica del paziente è importante tanto quanto i dati relativi alla sua capacità visiva. Durante la visita preoperatoria, dunque, è importante condividere con il medico l’anamnesi visiva, ossia l’insieme delle informazioni che possono essere rilevanti per risalire alla storia oculistica di un individuo, anche i dettagli che non vengono riportati nero su bianco.
Questa condivisione di informazioni avviene solitamente attraverso un confronto diretto tra paziente e medico, durante il quale vengono raccontati tutti i precedenti oculistici, dalla storia della miopia o degli altri difetti visivi, alle eventuali problematiche correlate.
In questo spazio di ascolto è possibile far emergere numerose informazioni, tra cui:
- Evoluzioni dei difetti visivi
- Dettagli sull’utilizzo di supporti visivi
- Difficoltà nella visione notturna
- Tolleranza o intolleranza alle lenti a contatto
- Sintomi visivi come vista offuscata, aloni attorno alle immagini, fotofobia, secchezza oculare, etc.
- Abitudini personali che prevedono l’affaticamento visivo
- Eventuali interventi o trattamenti precedenti
- Eventuali traumi oculari
- Farmaci in uso, sia per patologie o condizioni generiche, sia quelli oculari
È interessante anche notare che la condivisione di questa storia clinica non riguarda solamente il paziente, ma anche la sua famiglia, poiché molte problematiche visive e difetti refrattivi hanno una matrice ereditaria e dunque conoscere l’anamnesi familiare è importante tanto quanto quella del paziente.
Farmaci e sospensioni consigliate
Come anticipato sopra, ci sono delle piccole accortezze da prendere non solo in preparazione all’intervento, ma alla visita oculistica stessa, come per esempio l’interruzione dell’utilizzo delle lenti a contatto.
Questa pratica non è solo consigliata, ma necessaria per via del funzionamento stesso delle lenti. La lente a contatto è un supporto visivo che si appoggia direttamente all’occhio, nello specifico alla cornea, motivo per cui questa sezione dell’occhio subisce un minimo di pressione, influenzando la capacità refrattiva, ossia la messa a fuoco delle immagini. Prima di un esame oculistico è importante che l’occhio ritrovi la propria forma naturale, riducendo l’alterazione, per questo è importante sospendere l’utilizzo delle lenti a contatto nei giorni precedenti alla visita. In genere è sufficiente sospenderle per circa 1 settimana in vista del controllo di idoneità, e in seguito per 20 giorni prima dell’intervento, salvo indicazioni diverse da parte del medico.
Allo stesso modo è importante anche evitare alcuni tipi di farmaci, che potrebbero interferire con i risultati di alcuni esami.
Poiché questo aspetto può variare in base al farmaco e alla singola situazione, è bene comunicare il prima possibile quali farmaci vengono regolarmente assunti, in modo da farsi indicare in modo preciso quali evitare.
In base a quanto comunicato dal personale potrebbe essere necessaria la sospensione del cortisone o di colliri antibiotici.
Esami e test diagnostici
La visita di idoneità ha una durata di circa due ore e risulta particolarmente importante perché è in grado di evidenziare grazie a test approfonditi l’esatto stato di salute degli occhi del paziente. Non si tratta solo di dettagli accessori, ma di informazioni preziosissime per stabilire quale sia il trattamento più adatto alle esigenze visive del paziente e per la massima personalizzazione dell’intervento.
Gli esami visivi si svolgono tramite macchinari di ultima generazione, coniugando avanzamento tecnologico e competenza del personale medico.
Nello specifico, i test che vengono effettuati sono i seguenti:
- Autorefrattometria: test che misura il visus, ossia la capacità visiva del paziente. Questo permette di valutare l’entità del difetto visivo e la sua evoluzione nel tempo. In questa fase potrebbero emergere altre patologie.
- Pachimetria: misurazione dello spessore corneale e la pressione interna, per evidenziare eventuali patologie che alterano questi aspetti e un eventuale preclusione all’intervento.
- Biomicroscopia endoteliale: test corneale che coinvolge la sezione profonda di quest’area, nel tentativo di analizzarne le cellule.
- Topografia corneale: consiste nella mappatura della cornea, con un’attenzione particolare alla sua curvatura, la cui alterazione indica solitamente la presenza di cheratocono.
- Tomografia: analisi approfondita dello stato di salute dell’occhio, attraverso laser o infrarossi.
- Tonometria: esame fondamentale per analizzare la pressione intraoculare. Un’eventuale alterazione potrebbe far emergere la presenza di una patologia rischiosa, ossia il glaucoma.
- Esame del fondo oculare: tramite l’applicazione di un collirio che allarga la pupilla, l’oculista è in grado di esaminare componenti dell’occhio che normalmente sarebbero difficili da visualizzare, come retina, vitreo e nervo ottico, valutando la presenza di eventuali alterazioni.
- Cheratometria: in caso di astigmatismo, valuta l’entità del difetto e l’eventuale presenza di cheratocono.
Valutazione dell’idoneità
Effettuata la visita di controllo, lo specialista dispone del quadro completo necessario per comunicare al paziente la sua idoneità alla chirurgia refrattiva, oppure l’impossibilità a sottoporsi all’intervento.
Un’altro elemento importante che emerge a questo punto è anche il tipo di intervento più adatto alle esigenze del paziente, tra PRK, FemtoLasik, ReLeX SMILE, Presbyond, etc, a seconda del disturbo visivo e delle caratteristiche dell’occhio.
Tra le principali controindicazioni alla refrattiva di sono le seguenti condizioni, che potrebbero (non necessariamente), limitare l’idoneità:
- Non aver raggiunto la maggiore età
- Non avere una difetto refrattivo stabile da almeno 2 anni
- Avere uno spessore corneale ridotto, che entrerebbero in conflitto con l’azione del laser
- Essere in stato di gravidanza o allattamento, in quanto tale condizione ha un impatto sulla capacità visiva
- Soffrire di malattie autoimmuni come lupus e artrite reumatoide
- Essere affetti da diabete, una patologia che può intaccare cornea e retina e rendere rischioso l’intervento
- Presenza di patologie oculari come cheratocono, glaucoma o uno stato cronico e severo di secchezza oculare
- Presenza di infezioni oculari
- Presenza di malformazioni dell’occhio
Ognuna di queste condizioni – a cui possono aggiungersi casi più specifici – deve essere discussa singolarmente e in modo approfondito con il proprio medico oculista, in modo da valutare non solo la presenza del problema, ma anche la sua entità. La sola presenza di patologie non preclude infatti al 100% l’intervento, ma è necessario valutare caso per caso.
Consulenza e spiegazione del processo
Come avviene per ogni aspetto medico, la consulenza con uno specialista esperto è cruciale in questa fase, non solo per la precisione con cui gli esami devono essere eseguiti, ma anche per poter avere un confronto umano, prima ancora che medico.
In fase di consulenza, il ruolo del medico consiste nel mettere il paziente a proprio agio, rassicurandolo sulle elevatissima percentuale di successo dell’intervento e sui pochissimi rischi della chirurgia agli occhi. Tra questi possono esserci infezioni e infiammazioni, arrossamenti e irritazioni, possibili lesioni, visione offuscata, secchezza oculare e l’aumento della pressione interna, problematiche in genere passeggere o risolvibili attraverso appositi trattamenti.
Grazie alla sua competenza e conoscenza del settore, inoltre, potrà offrire una panoramica delle tecniche disponibili per la correzione del difetto visivo, come le tecniche Lasik, la PRK o le ICL.
- PRK: consiste l’asportazione delle cellule epiteliali sulla superficie della cornea, in modo che il laser possa rimodellare gli strati interni. Utilizzato per correggere miopia, ipermetropia e astigmatismo, solitamente di media e bassa entità. Recupero pieno della vista dopo circa 5 giorni dall’intervento.
- FemtoLasik: tecnica che combina laser femtosecondi e laser a eccimeri, che creano un lembo corneale, lo sollevano e agiscono sulla cornea, risolvendo il difetto di rifrazione. Permette di correggere miopia, astigmatismo e ipermetropia, anche di una certa entità e su pazienti affetti da cornea sottile. Il recupero visivo è possibile in poche ore.
- ReLeX SMILE: attraverso un laser a femtosecondi, viene creato un piccolo lenticolo personalizzato all’interno dell’occhio, che in seguito viene estratto con una piccola incisione, risolvendo il problema senza flap. Adatta a miopia e astigmatismo, anche combinati, di entità moderata.
- ICL: le lenti intraoculari, o lenti fachiche, sono indicate quando non è possibile intervenire con tecniche laser, che sia per difetti elevati o per uno spessore corneale inadeguato. Tecnica più invasiva, ma dai risultati eccellenti.
- Presbyond: tecnica che permette una correzione mirata e personalizzata della presbiopia. La tecnica usata viene definita Blended Vision e consiste nel correggere un occhio per la visione da vicino e uno per quella da lontano, in modo da bilanciare al meglio la messa a fuoco.